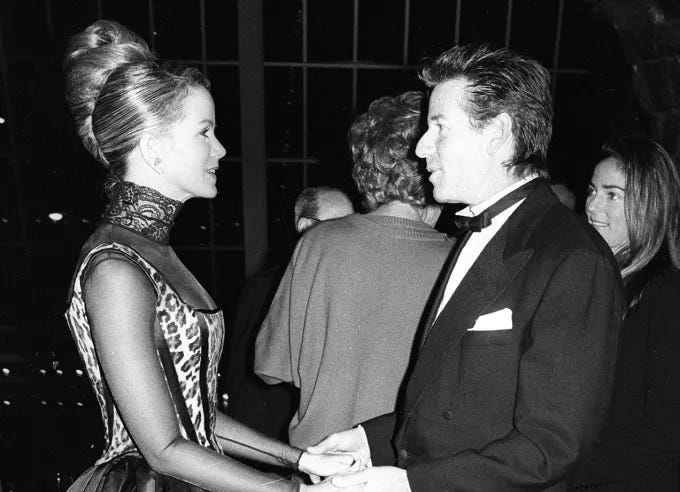#49: Met Gala: che voto ci meritiamo noi?
Il Met Gala ci offre un linguaggio per capire il mondo — ma solo se scegliamo di ascoltarlo davvero. Perché la moda non è solo da guardare. È da leggere. Ma forse non siamo pronti.
Ogni anno, puntuale come un esame di coscienza collettivo, il Met Gala ci ricorda che non siamo solo spettatori, ma giudici. E sta a noi decidere se cogliere — o ignorare — il senso profondo di temi che, fino a ieri, non avevano mai trovato spazio nella storia dell’evento.
Superfine: Tailoring Black Style lanciava un’àncora a chi ancora ignorava la ricchezza della creatività nera: una moda pensata e indossata nel corso dei secoli per affermare la propria identità. Ma cosa succede quando lo spettacolo rallenta e la provocazione cede il passo alla riflessione? Forse succede che non siamo più capaci di coglierla, distratti dai voti da giuria e dai like a caldo, finendo per sprecare l’occasione di imparare davvero qualcosa.
Lezione n.1: Come una cena benefica diventa macchina da guerra del capitalismo pop, capace di trattare qualsiasi tema
Nato nel 1948 come una cena di beneficenza ideata da Eleanor Lambert per raccogliere fondi destinati al neonato Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, il Met Gala era inizialmente un evento riservato ai pochi ricchi della città. Una serata discreta, elegante, frequentata dai socialite dell’Upper East Side che non vi avrebbero rinunciato per nulla al mondo.
I biglietti avevano costi contenuti — nulla a che vedere con gli attuali 75.000 dollari — e anche le mise riflettevano una certa sobrietà d’epoca: poche stravaganze, molta raffinatezza, tanto nella scelta degli abiti quanto nelle pose immortalate dai fotografi.
Un aspetto che cambia negli anni Novanta, quando Anna Wintour prende in mano l’organizzazione dell’evento. In quel momento, il Met Museum cerca una figura che possa rilanciare l’interesse attorno al Costume Institute: né uno stilista né un curatore museale, ma qualcuno che possa fungere da ponte tra modernità e cultura. La scelta ricade su una direttrice di rivista, forse la più influente del mondo.
Wintour percepisce subito il potenziale. L’appuntamento annuale è già soprannominato Party of the Year, ma non è ancora riconosciuto come un vero fenomeno culturale. E chi non fa parte di certi giri o non dispone di fonti dirette, difficilmente ne può sapere qualcosa. Nessuna diretta streaming, nessuna gallery social: solo sussurri, articoli del giorno dopo e pochi scatti rubati.
Fino a quel momento, è ancora possibile acquistare un biglietto senza essere celebri, alla modica cifra di 1000 dollari e per l’after-party ne bastano solo 150. Gli ospiti? Un mix di designer, figure della moda e celebrità che possono facilmente partecipare a qualsiasi raccolta fondi dell’alta società newyorkese.
Dal 1995, però, Wintour comincia a cambiare qualcosa. La lista degli invitati si restringe, le selezioni diventano spietate. Molti vengono rifiutati, anche più volte. Allo stesso tempo, i nomi giusti — come la principessa Diana, che nel 1996 partecipa in John Galliano — vengono caldamente suggeriti. Più celebrity, più hype. E più hype, più potere simbolico. Così il Met Gala conquista l’etichetta di “Oscar della costa orientale”. Un’espressione oggi anacronistica, perché l’evento ha da tempo superato, per impatto culturale, lo stesso immaginario hollywoodiano, superandolo.
Nei primi anni Duemila l’evento assume un aspetto ancor più definito: la lista degli invitati diventa così rigidamente controllata che persino volti noti e facoltosi, pur offrendo cifre considerevoli, si vedono negare l’accesso. È Anna ad avere in mente “il disegno finale” — dall’alto della sua divina provvidenza — ed è sempre lei ad avere l’ultima parola su chi sia o non sia abbastanza Vogue-ish per salire sul red carpet.
Con il tempo, la selezione si orienta sempre più verso figure artistiche e creative, a discapito delle celebrity mainstream (le sorelle Hilton non saranno mai ammesse e le Kardashian solo dopo numerosi tentativi). Un cambiamento che trasforma il Gala in una vera e propria installazione pop, dove ogni ospite è tassello di una narrativa estetica più ampia.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli:
Lo staff di Vogue incaricato di accompagnare gli ospiti all’interno del museo indossa abiti firmati, scelti e approvati dai caporedattori moda.
Camerieri e baristi vengono selezionati con attenzione, come se fossero parte integrante del tableau vivente.
Il celebre carpet non è quasi mai “red”: il colore cambia a seconda del tema dell’anno, connesso a quello della mostra — rosa per Camp; righe rosse, bianche e blu per Gilded Glamour; champagne e verde acqua per Sleeping Beauties: Reawakening Fashion; blu notte con narcisi bianchi e gialli per Superfine: Tailoring Black Style.
Rispetto agli anni Novanta e Duemila, i gradini non sono più in cemento grezzo, le tende anti-pioggia non sono più di plastica lucida e scadente, e la stampa non è più confinata dietro a cancelli di metallo. Wintour ha infatti optato per una tenda anti-pioggia di tessuto drappeggiato e la stampa è posizionata dietro una finta siepe rigogliosa, talvolta decorata con fiori. Un’evoluzione necessaria nell’era dell’estetica digitale, in cui ogni video e ogni scatto degli arrivi ha il potere di influenzare l’immaginario globale.
Il Met Gala ha anche cambiato posto nel calendario: non coincide più con quello autunnale e invernale — quando l’alta società newyorkese è impegnata in una giungla di eventi benefici — ma è stato spostato a maggio. Un timing strategico che lo rende più simile a un evento hollywoodiano che a una soirée dell’Upper East Side. Ed è proprio questo che gli ha permesso, negli anni, di diventare così grande e speciale.
Lezione n.2: Noi, spettatori sovrani
C’è un aspetto fondamentale da considerare in questo quadro: in un’epoca in cui l’istupidimento collettivo viaggia alla velocità dei social, le foto delle celebrity al Met Gala conquistano facilmente l’algoritmo, piombando anche sulle bacheche di chi non sa nemmeno cosa sia il Costume Institute. O forse Meta, che controlla Facebook e Instagram e sponsorizza l’evento, potrebbe farle emergere di proposito per ottenere il massimo risultato. Ma ciò che conta di più è che oggi gli utenti — ormai incapaci di mantenere vivo l’interesse per più di tre secondi — possono giudicare in meno di due, comodamente seduti sul divano di casa. Partecipano con i loro commenti e giudizi, ma soprattutto, decidono i vincitori e i vinti. Non siamo agli Oscar, qui non c’è una commissione istituita; sono loro i membri di un Academy virtuale, volatile e potenzialmente tossica. Eppure, in tutto questo, il Met Gala continua ad accadere, tra arte, costume, strategia e spettacolo.
E a chi avrebbe voluto cavalcare l’onda del capitalismo sfrenato che divora e cannibalizza ogni cosa, Wintour ha risposto con un tema tanto profondo quanto necessario, forse atteso da troppo tempo. Il dandismo nero è stato uno strumento per ripensare l’identità, per reimmaginare l’individuo in un contesto diverso dal solito. Ma proprio per questo, per alcuni è sembrato quasi distopico vederlo incorniciato in abiti lussuosi e coreografie da red carpet: più di una voce si è sollevata per denunciare il rischio di spettacolarizzare, ancora una volta, una realtà complessa e carica di significato. Un’estetica potente, certo, ma il cui significato rischia di perdersi se non accompagnato da consapevolezza.
Il passo falso è sempre dietro l’angolo quando si sceglie di mettere sotto i riflettori un tema complesso, molto più delicato di un omaggio al designer di turno (Karl Lagerfeld nel 2023) o a un’epoca sfavillante (Gilded Glamour nel 2022). La percezione diffusa è stata quella di una serata elegante ma sottotono: abiti belli, giusti, coerenti, forse troppo. E va da sé che quando c’è poco da giudicare con il coltello tra i denti, inevitabilmente, si spegne anche parte del divertimento per il pubblico.
Un tema che ha fatto incassare meno per questo? Assolutamente no. Nel 2024 la serata ha fatturato 22 milioni di dollari, quest’anno si è raggiunta la cifra record di 31 milioni (nonostante mancassero star del calibro di Selena Gomez, Billie Eilish, Beyonce, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Lady Gaga e Katy Perry). A dimostrazione che, quando il sistema moda decide di raccontare una storia — anche scomoda — riesce comunque a monetizzarla fino all’ultimo centesimo.
Chi ha liquidato il Met Gala come “noioso” o “poco entusiasmante” ha perso l’occasione di approfondire un tema che, per troppo tempo, non ha avuto lo spazio che meritava. La creatività nera si è espressa attraverso scelte estetiche consapevoli (Colman Domingo in Valentino tributando André Leon Talley), reference storiche (Rosa Parks su un look Louis Vuitton) e collaborazioni potenti (Lewis Hamilton + Grace Wales Bonner). E se non sono mancati abiti discutibili, è altrettanto vero che il messaggio — per una volta — valeva più del meme del giorno.
Quale voto ci diamo, allora?
Insufficiente se ci siamo accontentati della solita dicotomia bello/brutto, divertente/noioso.
Sufficiente se abbiamo provato almeno a cogliere i riferimenti, a leggere i dettagli, a non ridurre tutto a un meme.
Distinto, se ci siamo chiesti cosa significhi davvero portare certi simboli sotto i riflettori.
Ottimo, se per una sera abbiamo scelto di guardare e imparare, invece che solo giudicare.
Lezione n.3: Imparare a leggere i messaggi dietro ai vestiti
Wintour — unica costante in un settore volubile per natura — ha ribadito anche quest’anno che il Met Gala — massima manifestazione del suo potere — non è solo una sfilata glamour, ma uno strumento potentissimo di influenza culturale, sociale, economica e politica.
Se lì, su quei gradini, avviene la sua incoronazione annuale, si riflette anche il modo in cui la moda oggi racconta — e dirige — il nostro tempo.
La scelta di dedicare un’intera mostra alla Black culture in oltre VENT’ANNI di Costume Institute è un atto necessario, ma anche audace. In un’America dove la narrazione sulla blackness è sempre più minacciata — tra il ritorno strisciante del privilegio bianco e il tentativo di silenziare le minoranze in nome della “neutralità” — le istituzioni culturali sono finite nel mirino di governi ostili, accusate di “militanza” per aver dato spazio a storie diverse da quella dominante.
Il tema era già in programma dal 2020, quando l’omicidio di George Floyd ha costretto il Paese a fare i conti con i propri fallimenti strutturali in materia di giustizia razziale. E oggi, mentre l’amministrazione Trump delinea un futuro sempre più ostile alla diversità culturale, l’industria della moda ha voluto dimostrate di essere pronta — o quantomeno abbastanza matura — per affrontare apertamente un tema complesso, provando a sanare ferite mai guarite. Per troppo tempo, infatti, la relazione tra il sistema moda e la cultura nera è stata segnata da appropriazioni, esclusioni e silenzi.
N.B: solo l’11% dei ruoli dirigenziali nella moda è ricoperto da persone di colore.
Come hanno risposto i black creatives interpellati?
Dal punto di vista estetico, non hanno deluso le aspettative: abiti sartoriali e raffinati hanno interpretato il dandismo afroamericano con eleganza e ironia, richiamando alla mente la celebre citazione di George C. Wolfe:
Dio ha creato i neri, e i neri hanno creato lo stile.
Grace Wales Bonner, promettentissima designer anglo-giamaicana, ha realizzato per Lewis Hamilton un completo avorio carico di simbolismi: il colore alludeva a purezza e status, mentre gli amuleti cuciti sugli accessori evocavano l’eleganza rituale del dandy afroamericano.
Willy Chavarria, stilista newyorkese, ha sfoggiato il suo Zoot Suit in seta rosa, omaggio alle sue radici latine e alla storica “uniforme” delle minoranze negli anni Quaranta: spalle ampie, vita stretta e pantaloni oversize con pieghe profonde. Una versione floreale è stata pensata per l’amico Maluma.
Dapper Dan, iconico designer di Harlem, ha disegnato il proprio outfit ispirandosi al Sankofa, simbolo Akan ghanese che gli schiavi marchiavano sulle opere in ferro durante la colonizzazione.
Pharrell Williams, in veste di direttore creativo di Louis Vuitton (sponsor della serata), ha firmato diversi look, tra cui il tailleur bianco svasato indossato da Zendaya — ispirato agli Zoot Suits ma anche a Bianca Jagger nel giorno delle nozze e a Diana Ross nel film Mahogany del 1975. Per Sabrina Carpenter, ha invece ideato un abito che rende omaggio a Zelda Wynn Valdes, prima stilista nera ad aprire un atelier a Manhattan nel 1948 e autrice delle iconiche uniforme delle conigliette di Playboy.
Colman Domingo, co-presentatore della serata, si è presentato con una lunga mantella Valentino blu brillante, richiamando quelle indossate da André Leon Talley, figura leggendaria della moda scomparsa nel 2022. Quella tonalità di blu era quella che da uno dei dandy più importanti della storia scelse nel giorno della sua liberazione dalla schiavitù.
Jodie Turner-Smith in Burberry: l’attrice ha reinterpretato la silhouette vittoriana con un total look in pelle ispirato alla cavallerizza nera Selika Lazevski, figura affascinante della Parigi Belle Époque.
Teyana Taylor ha collaborato con la costumista Ruth E. Carter — prima donna di colore a vincere due Oscar nella storia dell’Academy. Un abito burgundy che rileggeva lo Zoot Suit in chiave contemporanea. La mantella, ricamata a mano, portava con sé un messaggio potente, soprattutto per Harlem, dove questo completo ha radici profonde.
Molti altri stilisti neri, anche emergenti, hanno finalmente ottenuto la visibilità che meritano: dal nigeriano Ugo Mozie, che ha vestito Diana Ross, a Torishéju Dumi, scelta da Kendall Jenner.
Ma è soprattutto con la mostra del Costume Institute — ispirata al libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity di Monica L. Miller (2009) — che la moda black ha conquistato un palcoscenico pienamente legittimato. Non solo nello spettacolo, ma anche nella narrazione culturale e storica del Met.
E ora che il sipario si è chiuso sulla notte più seguita dell’anno, resta da vedere se lo stesso entusiasmo verrà riservato all’esibizione. Perché, se è vero che, le persone di colore continuano a essere sottorappresentate ai vertici dell’industria della moda, è altrettanto vero che la loro influenza è — e resta — fondamentale.
Ricordiamoci che il Met Gala non è solo una parata di abiti, ma un potente atto culturale. Ignorarne il significato sarebbe un’occasione persa. Perché, alla fine, se c'è qualcosa di davvero superficiale, non è la moda. Siamo noi.
News Met Gala:
L’importanza del Met Gala: c’è chi annuncia la gravidanza lì
La bellissima foto di gruppo delle celeb vestite in total Louis Vuitton
News of the Week:
Notizie belle: l’ultra-fast Fashion di Temu e Shein rallenta in USA
Il guest di Pitti Uomo 108 è orgogliosamente italiano: chi è
Tutti i finalisti del CNMI Fashion Trust Grant qui
La gatta di Lagerfeld ancora protagonista in una campagna pubblicitaria
Formula1 Star: dopo Louis Vuitton come main sponsor al posto di Rolex e Hamilton protagonista al Met Gala, Ferrari lancia una collaborazione con Leclerc e Adidas con Mercedes-AMG Petronas
XXX